Memorie Della Banda Musicale Di Assergi (laboratorio delle memorie)
Torno a ricordare quando, negli orti, vicino all’insalata, ai cavoli, ai pomodori, alle verdure e i sensi, si seminavano, per i morti i crisantemi.
Tempi di medesima fame di carne e memoria. Il corpo, l’anima e il dolore si innaffiava con la stessa acqua. Negli stessi orti, ch’erano orti d’habitus comune e condiviso, si coltivavano le stesse vocazioni.Vocazioni che elevavano, compresa la musica, l’arte sovrana, quella nella quale si liquefano tutte le altre. Quella simpatetica che pervade senza subalternità ancillari. Che nell’ascolto, trova accordi con le vibrazioni delle corde interne.
Arte che, perseguita con determinabilità esecutiva, necessita di sensibilità, scuola e cultura.
Affinamento di sensibilità, scuola, cultura e perseguimenti, tutto coltivato nell’orto comune di Assergi e di molti paesi, dall’ottocento fino ai primi anni del novecento.
Da una memoria, ritrovata da Franco Dino Lalli, tra i documenti, che in fotocopia s’allegano; proprietà custodita dal padre Giambattista Lalli, nonché mio zio, di compilazione anonima, si evince che la banda musicale di Assergi, era patrimonio culturale, fin dagli anni di fine ottocento.
Si può ipotizzare che l’estensore ignoto di questa memoria, probabilmente l’ha redatta qualche decennio dopo, da evidenze di prima mano o da racconti avuti e il suo fine quello di perpetuare quanto di sua conoscenza, senza interrogazioni storiche più stringenti, senza avere precisa contezza a quali tempi risalisse la tradizione di coltivare, nell’orto comune di Assergi, la musica e la istituzione della banda. Probabilmente da tempi ancora più lontani.
Affinamento di sensibilità, scuola, cultura e perseguimenti, tutto coltivato nell’orto comune di Assergi e di molti paesi, dall’ottocento fino ai primi anni del novecento.
Da una memoria, ritrovata da Franco Dino Lalli, tra i documenti, che in fotocopia s’allegano; proprietà custodita dal padre Giambattista Lalli, nonché mio zio, di compilazione anonima, si evince che la banda musicale di Assergi, era patrimonio culturale, fin dagli anni di fine ottocento.
Si può ipotizzare che l’estensore ignoto di questa memoria, probabilmente l’ha redatta qualche decennio dopo, da evidenze di prima mano o da racconti avuti e il suo fine quello di perpetuare quanto di sua conoscenza, senza interrogazioni storiche più stringenti, senza avere precisa contezza a quali tempi risalisse la tradizione di coltivare, nell’orto comune di Assergi, la musica e la istituzione della banda. Probabilmente da tempi ancora più lontani.
Dal documento si apprende l’anno della prima costituzione di una banda ad Assergi, risalente al 1889, con un primo maestro con cognome Duronio, probabilmente non direttamente discendente di Assergi, il quale aveva un figlio Guido che all’età di otto anni era già provetto suonatore di clarinetto, a testimonianza della precocità degli insegnamenti impartiti con valenza di perpetuazione di un patrimonio comune, del sangue culturale e di elevazione di una comunità, quasi fosse un necessario rito di passaggio, da perseguire già in tenera età.
Questo non vale solo per il figlio del maestro di musica, ma anche per tutti i bambini, ai quali, con questa proposizione acculturante, si prometteva anche uno sgravio dalle fatiche che precocemente avrebbero iniziato ad assediare.
La precocità di tali insegnamenti è ben evidente nella fotografia, che proficuamente ha colonizzato e avuto perpetuazione fino a noi, quasi in tutte le case di Assergi, dove è evidente come su un totale di 23 elementi, più di un terzo mostra un’età al di sotto della maggiore età, anzi sono decisamente bambini.
Si menziona il successivo maestro Fasoli, anch’egli con un cognome non propriamente assimilabile ad una diretta discendenza paesana, del quale si narra un aneddoto colorito riguardo le sue frequentazioni muliebri, in particolare con una probabile fanciulla assergese e le conseguenze cui voleva sottrarsi, in fuga verso l’America, come nelle similari vicissitudini, però con esiti meno esiziali, narrate in cronaca di una morte annunciata, da Gabriel Garcia Marquez. In questo caso l’epilogo non è tragico ma la ricomposizione soggiacque alla consuetudine codificata del ristoro matrimoniale.
La banda sì che ristorava dagli assedi, dalle strettezze del vivere, anche dei paesi limitrofi fino a L’Aquila, proponendo un rinvigorito apporto di nuova elegia, nel capoluogo, come già offerto al tempo della sua edificazione, con il contributo di tutti i castelli del circondario.
Si narra come la grande guerra del 15-18, interruppe l’uso dell’anima e mise in mano agli uomini strumenti, senza articolazione armonica, solo con bitonalità tragica.
Fortunati furono solo tre, che ebbero la ventura, per qualità personali, come attestato dal rendicontante del manoscritto, o solo per la ragnatela del caso, che poterono affrancarsi dai fucili e dai cannoni e continuarono ad imbracciare uno strumento di pace, nella banda Reggimentale del 13° Fanteria di L’Aquila che partecipò alla grande guerra con compiti di conforto, sprone patriotico, rifocillamento estetico e ritempro, nelle oasi di retroguardia; dove per poco allo stillicidio sacrificale e rumorale della guerra, concedevano il respiro ordinato, metronomo della musica, che elevava oltre le grettezze manichee.
Come riferito, tre i migliori, per qualità musicali: Mosca Arcangelo, che sarà il maestro della ricostituita banda dopo la guerra, già negli anni 1919-20. Banda agognata e riformata appena la fine degli eventi bellici. Ovvero negli anni in cui occorreva ricordare,forse più dimenticare, venerare i periti, ricucire con i fili multicolori che concede la musica, per colorare la bianca tela dell’attonito silenzio, dopo l’evento tragico della guerra, seppure l’esito proficuo, in termini militari, politici e riconquistata unità nazionale.
Dei tre, compreso Mosca Arcangelo, cui fa esplicito riferimento lo scritto, fanno parte mio nonno Laurino Lalli e Giusti Gennaro.
Di Mosca Arcangelo, in questo scritto, si celebrano i suoi virtuosismi, quasi un Paganini del clarinetto, con aneddoti che richiamano la storia di Danny Boodman T.D.Lemon, narrato con il nome di novecento, nell’omonimo romanzo da Baricco, dove si racconta inoltre come lui superasse in bravura un grande pianista e riuscisse ad accendere una sigaretta dalle corde arroventate del pianoforte, nel caso di Arcangelo, di come riusciva contemporaneamente a suonare e fumare o sopperire ad una rottura meccanica dello strumento.
In queste note traspare la sua estemporaneità, la padronanza della musica, della vita, della sua coinvolgente giovialità, non la sua vulnerabile dipendenza riguardo le sollecitazioni e beltà muliebri cui, scevro di autocontrollo, soggiaceva spesso.
Si narra come dopo la guerra egli, quale primo brano proposto alla collettività, fece eseguire una sua trasposizione musicale dell’"Italo Sasso", su testo letterario scritto dal prete di Assergi Don Ermanno Morelli e come si prodigò a preparare i nuovi adepti bambini e ragazzi, reclutati nella banda.
A questo proposito so che anche mio nonno era pronto, si prestava e s’adoperava, in quegli anni e nei successivi, a instillare alle nuove leve il fuoco sacro dell’arte musicale, usando con compitezza tutte le crome e biscrome empatiche.
I tre musicanti di elezione, come tutti, schiavi del tempo e della comune storia, furono inghiottiti prima dal servizio militare, che allora rubava tre anni della propria vita e, allo scadere, senza soluzione di continuità, vennero risucchiati dal ciclone della grande guerra, che velò le loro sensibilità, allertate dalla musica, con un telo di artefazione codificata, compassata, quasi da requiem, per i servizi funebri, le paludate parate istituzionali e per la morte di un vissuto intimo, non più affrancabile.
Mio nonno e, come presumo, anche Mosca Arcangelo, erano nati nel 1892, per cui appena stava per terminare il servizio militare, senza interruzione, per l’avvento della guerra, furono spediti al fronte.
So per certo, come mio nonno mi raccontava, che lui tra servizio militare e guerra aveva perso, senza interruzione, sette anni di vita e di sogni.
Mio nonno Laurino, già da bambino di sogni ne aveva tanti, già da quando al mulino, con il padre attendeva la musica del fiume, che lo educasse all’ascolto, oltre la codifica dei neumi musicali che gli venivano trasmessi, per derivale lascito parentale.
Oltre la macina, che d’ogni seme e tempo fa polvere, il fiume ritrovava una rinascenza trasformata e faticata, con i toni amari del rancore, per avere incontrato la subbiezione degli uomini. Il suono s’infletteva ad una legatura nei crescendi, conTorno a ricordare quando, negli orti, vicino all’insalata, ai cavoli, ai pomodori, alle verdure e i sensi, si seminavano, per i morti i crisantemi. una smania di fuga.
Lontano forse dimenticava gli accidenti, rimeditava uno scherzo, un divertimento coscienzioso e, capiva il pathos dei notturni.
Mio nonno la comprese quella musica. Capì come tutte le storie e le arti, trovano asilo e giustificazione in musica.
Lui conoscitore del solfeggio, della cospirazione frazionaria delle battute, le escursioni della scala diatonica, il florilegio di quella cromatica, quella maggiore, con i semitoni persi tra la terza e la quarta, la settima e l’ottava nota; la minore naturale, melodica ed armonica, fino ad avere, senza frequentazione, il sentore di quella pentatomica speziata d’oriente.
Dopo questi anni, quando io iniziai ad avere frequentazione con mio nonno, dagli anni 61 in poi, vidi spesso come lui, con la matita da falegname, umidita nella bocca prima dell’esercizio di scrittura, soggiacesse al richiamo di quell’arte, anche negli ambiti temporali dell’arte della falegnameria, la quale anch’essa si pregia di sperimentare compartimentazioni matematiche e compositive, germinanti nello stesso orto della fantasia e lo vedevo comporre pentagrammi, su carta di fortuna, o pezzi di tavole, le melodie che la memoria e le suggestioni creative, gli suggerivano, le quali sole salvano l’infinitezza del silenzio umano.
Fu la musica, appresa, già da bambino, col padre dal fiume, che si salvò. Che gli accordò in un solfeggio filosofico tutti i suoi umori vitali.
Con la diluizione dei suoi accenti, poliedrici nella banda reggimentale, a Caporetto, nella guerra del quindici-diciotto, con la musica si salvò. Con il flicorno tenore s’affrancò dall’ottusità dei fucili e delle baionette, restando a misura di salvazione dal fronte.
Mi raccontava come dopo la disfatta di Caporetto e il ritiro repentino oltre il Piave, con circa 350.000 sbandati e 300.000 prigionieri, senza contare i morti, con l’avvicendamento di Armando Diaz a Cadorna, l’infusione di nuove corroborazioni patriotiche, anche con il favore della banda regimentale, cui lui faceva parte, vi fu riorganizzazione e fu possibile procedere verso il riscatto.
Ricordo come lui odiasse Mussolini che aveva perso quanto da quella generazione conquistato con grande sacrificio, tutta l’Istria e le amene cittadine di Pola e Fiume che lui aveva conosciuto e che mi descrisse.
Ma questa è un’altra storia e, purtroppo un’altra guerra.
La musica gli aveva aperto l’udito, e i sensi alla comunione con il mondo e novantacinque anni dopo gli servì da sereno traghettamento verso l’ignoto.
A novantacinque anni, per novantacinque anni, quattro mesi e sedici giorni, odorò, anche col naso, che lo divideva per gli odori sognanti dei legni, le melodie del fiume e dell’aria, trascrivendole su morsi occasionali di carte e cartoncini o su tavole di falegname, che nella mia infanzia vidi ogni dove, senza mai comprenderne i trasporti elegiaci del suo animo.
A novantacinque anni ed oltre, un giorno, dopo essersi riposato, quando aveva riiniziato a suonare, con l’armonica a bocca, con cui pescava tra le macine dei ricordi, i ballabili, le polke, le mazurche, i tanghi, le villotte e le marcette, entrò nelle salmodie del suo fiume, con quella musica e se la portò, come il pifferaio magico nell’altro mondo, dove forse trovò che, anche la luce immane era, anch’essa musica, ed egli già esaudiva le melodie eterne.
Non capivo e, ancora ora, forse non capisco, quegli uccelli neri posati sulle corde liriche dei suoi pentagrammi, quelle rondini leggere, che con la loro indole migratoria ossequiavano le sue fughe armoniche, misurate tra le necessità del grano, delle farine, della falegnameria, della contadinanza e della famiglia. Anche se in tutte queste altre, di arti, metteva la stessa mitezza metodica ispirata.
Capisco, forse, la metafora, che perpetuò nella stalla, dove, la scala orizzontale, per fare risiedere la notte, le galline, era anch’essa pentamera, con cinque pioli.
Chissà quali temi gli ispirarono la casualità pigra nelle posizioni delle galline? Ancora un breve aneddoto, forse solo una coloritura, che è un mio ricordo personale. Quand’egli ormai novantenne, io andavo a trovarlo, per il piacere di trovarlo, lo scoprivo ritto, con una bacchetta nella mano destra, da lui stesso sagomata, mossa a modo nell’aria, con la radio accesa ad alto volume, su un programma di musica, come un direttore di una immaginaria orchestra sinfonica.
Nel testo di cui si parla, sono descritti gli elementi base costituenti la ricomposta banda, ognuno con il proprio strumento musicale.
Nel caso di Laurino Lalli si fa riferimento generico al bombardino.
Io so per espressa narrazione di mio nonno che il suo era, in verità il flicorno tenore. Intendo quello che suonò in guerra e nella banda perché in realtà sapeva suonare anche l’armonica, che volle che gli comprassimo e fu la compagna discreta della sua vecchiezza, forse anche altri strumenti a fiato e perfino la chitarra, come mi dette prova, quando io dopo innumerevoli suppliche a mia madre riuscii ad averla. Una chitarra ECO, piccola che lui iniziò insegnandomi gli accordi, benché le sue dita di vecchio indurite e sclerotizzate dai lavori e dalla vita, non entrassero entro i circoscritti tasti.
Lo strumento che rappresentò la sua salvezza, che il destino gli aveva messo tra le mani era appunto il flicorno tenore, detto anche bastudda, basflicorno o clavicorno in si bemolle, in tedesco: tenorhorm, poiché l’invenzione risale al 1820 in Austria, appartenente alla famiglia degli ottoni e sottofamiglia dei flicorni, suonato tramite pistoni o cilindri costruito sia in forma verticale, con la campana rivolta verso l'alto, o in forma ovale o più tondeggiante, con l’apertura laterale.
Il flicorno tenore ha un canneggio più sottile e maggiormente cilindrico però di eguale lunghezza rispetto al flicorno baritono e rispetto a quest'ultimo s’inerpica più facilmente verso il registro acuto.
Il tenore esprime dunque le sue peculiarità nell'ottava media e acuta, dove si accentua la differenza del suo timbro dal flicorno baritono.
Per queste peculiarità tonali e di registro, fu scelto dal compositore napoletano Alessandro Vessella, grande innovatore della banda, per ricoprire il ruolo del tenore lirico nelle trascrizioni operistiche, ruolo che, principalmente in Italia, mantiene tuttora.
Ricordo come questo strumento, fino agli anni 67-68 era appeso ad una corda del soffitto della casa di mio nonno e una estate, in concomitanza della festa del 5 giugno o di ferragosto, mio nonno ormai settantaseienne o giù di lì, lo vendette, a poco prezzo, ad un suonatore della banda, che torno a ricordare quando, negli orti, vicino all’insalata, ai cavoli, ai pomodori, alle verdure e i sensi, si seminavano, per i morti i crisantemi.
Lo strumento che rappresentò la sua salvezza, che il destino gli aveva messo tra le mani era appunto il flicorno tenore, detto anche bastudda, basflicorno o clavicorno in si bemolle, in tedesco: tenorhorm, poiché l’invenzione risale al 1820 in Austria, appartenente alla famiglia degli ottoni e sottofamiglia dei flicorni, suonato tramite pistoni o cilindri costruito sia in forma verticale, con la campana rivolta verso l'alto, o in forma ovale o più tondeggiante, con l’apertura laterale.
Il flicorno tenore ha un canneggio più sottile e maggiormente cilindrico però di eguale lunghezza rispetto al flicorno baritono e rispetto a quest'ultimo s’inerpica più facilmente verso il registro acuto.
Il tenore esprime dunque le sue peculiarità nell'ottava media e acuta, dove si accentua la differenza del suo timbro dal flicorno baritono.
Per queste peculiarità tonali e di registro, fu scelto dal compositore napoletano Alessandro Vessella, grande innovatore della banda, per ricoprire il ruolo del tenore lirico nelle trascrizioni operistiche, ruolo che, principalmente in Italia, mantiene tuttora.
Ricordo come questo strumento, fino agli anni 67-68 era appeso ad una corda del soffitto della casa di mio nonno e una estate, in concomitanza della festa del 5 giugno o di ferragosto, mio nonno ormai settantaseienne o giù di lì, lo vendette, a poco prezzo, ad un suonatore della banda, che torno a ricordare quando, negli orti, vicino all’insalata, ai cavoli, ai pomodori, alle verdure e i sensi, si seminavano, per i morti i crisantemi.
Ancora nel racconto del testo sono ricordati episodi dei vari periodi di escursioni della banda nei paesi limitrofi, con ricordi teneri e ricchi di piccole facezie e un celiare ingenuo e buono.
Questo documento ritrovato, consistente in due pagine, scritte con calligrafia, anche se con buona educazione, un po' stentorea, da cui si arguisce che potrebbero essere memorie di un non più giovane, ha valenza di piccola importante testimonianza storica, su una tradizione che ha costituito vanto e grande pregnanza sociale e culturale del paese.
Questo documento ritrovato, consistente in due pagine, scritte con calligrafia, anche se con buona educazione, un po' stentorea, da cui si arguisce che potrebbero essere memorie di un non più giovane, ha valenza di piccola importante testimonianza storica, su una tradizione che ha costituito vanto e grande pregnanza sociale e culturale del paese.
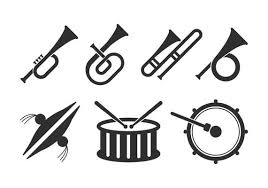









Commenti
Posta un commento